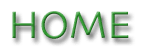|
Nel nostro istituto il prof. Mario Guerrini ha fatto degli studi per realizzare delle macchine per imparare la Fisica, denominati Exhibit; fra le macchine studiate, la prima è anche stata realizzata e fa parte di una mostra itinerante che annualmente gira in Italia.
Primo Exhibit (1998) Il modello didattico funzionante, qui descritto, mostra il rotore di un motore elettrico asincrono monofase fisicamente separato dallo statore, costituito da un magnete a forma torica di materiale ceramico forato al centro. Una bacchetta di vetro lo impernia e lo sostiene sollevandolo leggermente rispetto ad un piatto di cristallo mediante due appositi sostegni laterali anch'essi di cristallo. Lo statore è costituito da un nucleo ferromagnetico introdotto in una bobina da 500 spire alimentata dalla corrente della rete. Lo statore non è visibile perché è nascosto sotto il piano di appoggio di un comune tavolino su cui è collocato il piatto che porta il rotore (la rotazione del rotore è per l'osservatore un evento incredibile e di grande curiosità). Per scopo didattico proponiamo tuttavia una seconda versione funzionante più comoda, qui sotto descritta. Si costruisce il rotore servendosi di un magnete cilindrico forato al centro, di materiale ceramico, posto in levitazione tramite la polarità omonima di un secondo magnete fissato con colla epossidica sul fondo di un recipiente di vetro.Una bacchetta di vetro impernia al centro i due magneti collimandoli, permettendo così al magnete superiore di poter ruotare in levitazione attorno ad essa. Per statore servirsi di un nucleo lineare ferromagnetico introdotto in una bobina da 250 spire alimentata da corrente alternata (da 20 a 24 volt) di un trasformatore monofase. (Si parla di trasformatori in uso nei laboratori di Fisica. I trasformatori smontati forniscono un segmento lineare dell'intero nucleo ferromagnetico). Rotore e statore sono fisicamente separati, ma sarà sufficiente avvicinare, anche ad una certa distanza, lo statore al rotore perché questi si disponga instantaneamente in rotazione. E' stato ottenuto un motore elettrico monofase asincrono (parte cioè da fermo senza doverlo porre in rotazione ad una ben determinata frequenza per assicurare la continuità al movimento). Il dispositivo è di estrema semplicità costruttiva. La rotazione può avvenire, casualmente, in senso orario oppure antiorario. Per capire il funzionamento prendere conoscenza del motore elettrico trifase a campo magnetico ruotante dovuto a G. Ferrarsi. Ma, attenzione, questo è un monofase e non un trifase. E' possibile dare una soddisfacente spiegazione del suo funzionamento? La spiegazione del funzionamento è del tutto simile a quella del rotore elettrico a campo magnetico rotante o motore asincrono inventato dall'ingegnere italiano Glielo Ferrarsi (1847-18796). Il motore comprende una parte fissa esterna (statore) costituita da tre bobine disposte a 120° l'una dall'altra come gli indotti di un alternatore trifase, ed una parte mobile centrale (rotore), formata da un cilindro metallico oppure una gabbia cilindrica libera di ruotare su di un perno centrale. Quando si alimentano le bobine dello statore con i tre conduttori di una linea trifase, nella zona centrale del motore si genera un campo magnetico che ruota con velocità angolare pari alla pulsazione w della corrente di alimentazione. Nelle varie parti del rotore, a causa della rotazione del campo B in cui si trova immerso, si ha una variazione di flusso che provoca l'insorgente di extracorrenti di Foucault. Queste, per la legge di Lenz Tendono ad opporsi alle variazione che le generano, in questo caso al moto relativo campo-rotore; di conseguenza il rotore si mette in movimento seguendo la rotazione del campo. Il rotore, nel seguire il campo, non mantiene la stessa velocità angolare w del campo rotante ma, in genere viene trascinato ad una velocità minore; il divario fra le due velocità è tanto maggiore quanto maggiore è lo sforzo meccanico che il motore deve fare. Lo sforzo meccanico è anche volutamente nei due sensi della rotazione per cui il motore ruota solamente nel verso prestabilito, mentre nel caso nostro, essendo lo sforzo meccanico uguale in entrambe le parti, accadrà che il rotore possa mettersi in movimento sia in senso orario che antiorario in modo del tutto causale. Infine, per concludere, ricordiamo che i magneti di forma cilindrica (forma torica) presentano le rispettive polarità sul cerchio superiore ed inferiore e le linee di forza si concatenano con il verso da Nord a Sud. Secondo Exhibit (1998) "Dispositivo idoneo ad evidenziare il fenomeno fisico della "Riflessione multipla" perfettamente visibile per tutti gli osservatori che si trovino fuori da un sistema riflettente costituto da due specchi piani e a paralleli". Il fenomeno della riflessione multipla è facilmente visibile ad un qualsiasi osservatore che si sottopone ad un taglio di capelli, cioè quando il medesimo è posto fra due specchi piani disposti parallelamente (sistema quindi costituito da primo specchio piano / osservatore / secondo specchio piano). Lo scopo del presente progetto è quello di ottenere lo stesso effetto visibile ad un osservatore posto all'esterno del sistema e cioè: osservatore / specchio / sorgente di luce / specchio. Abbiamo pertanto realizzato un dispositivo ad uso didattico quale progetto dimostrato per una insegna luminosa ad effetto "Tunnel". Uno specchio semiriflettente ha la proprietà di comportarsi da specchio se la sorgente di fuori è dalla parte dell'osservatore, mentre diventa trasparente come una qualsiasi lastra di vetro se la sorgente di luce è dalla parte opposta rispetto all'osservatore. Prendiamo ora un comune specchio piano e disponiamogli parallelamente uno semiriflettente con la sorgente luminosa collocata nell'interno alle due lastre. La sorgente "vede" di fronte a sé il semiriflettente come uno specchio che forma un'immagine virtuale che a sua volta si riflette sullo specchio retrostante producendo una frequenza multipla ed indefinita di immagini. L'osservatore vede, attraverso il semiriflettente come un vetro, la stessa sequenza multipla però nella profondità dello specchio. Quindi per ottenere questo fenomeno di grande effetto è sufficiente disporre di uno specchio, di una sorgente luminosa e di un vetro semiriflettente facilmente reperibili in commercio. Disponiamo le due lastre in modo perfettamente parallelo ad una qualsiasi sorgente luminosa nel loro interno. Si possono costruire insegne luminose ad immagini multiple che danno luogo ad un effetto di grande profondità come se si osservasse un lungo tunnel illuminato nel suo interno (fig. n.4). Maggiore è l'intensità luminosa della sorgente, maggiore sarà il numero delle immagini prodotte. Quindi dal numero delle immagini si può pertanto avere un termine comparativo della luminosità di più sorgenti in esame a stabilirne il confronto. Terzo Exhibit (1998) STIMOLATE DA CARICHE ELETTROSTATICHE CORPOREE Il dispositivo, realizzato in due versioni funzionanti, consente di dimostrare come le poche cariche elettrostatiche, sempre presenti o quasi sulla superficie esterna del nostro corpo, siano più sufficienti ad innescare una scarica elettrica nei gas rarefatti. Un normale tubo a neon per illuminazione alimentato dalla corrente della rete è inserito in un circuito caratterizzato da seguenti elementi: 1. Una induttanza data dal reattore 2. Uno starter 3. Uno o più condensatori utili solo per il rifasamento della corrente, ma non indispensabili alla funzionalità del tubo. L'induttanza ha lo scopo di dare una scarica di alta tensione ma contemporaneamente presenta una forte resistenza, detta reattanza, necessaria per ridurre l'alta intensità di corrente che altrimenti danneggerebbe il tubo compromettendo la funzionalità. Lo starter ha la funzione, mediante brevi impulsi, di innescare la prima scarica elettrica che poi si autosostiene. Il dispositivo, che è stato realizzato in due versioni, elimina sia il reattore che lo starter e lo schema elettrico è di una semplicità estrema che tuttavia comporta un sottile ragionamento. Nella prima versione, il tubo a neon di 6 watt è semplicemente posto in serie ad una lampadina elettrica da 4 watt, alimentata dalla corrente della rete a 220 volt come da schema. Il filamento di una lampadina si comporta come una resistenza variabile (alla reattanza si è sostituita una resistenza ohmica), di basso valore a filamento freddo per divenire di valore notevole a filamento incandescente. Quindi solo inizialmente ed in un intervallo di tempo infinitesimale, il tubo a neon sarà percorso da una forte intensità di corrente necessaria a produrre la quantità ottimale di ioni in senso al gas perché la scarica si autosostenga e poi l'intensità diminuirà fortemente per l'alto valore della resistenza che viene ad instaurarsi impedendo il danneggiamento del tubo. Per un maggior chiarimento riportiamo i seguenti dati numerici: la lampadina da 4 watt posta in serie al tubo a neon presenta una grande resistenza ohmica come risulta dalla risoluzione dell'equazione della potenza elettrica: W = i D V quindi I = W/ DV = 4/220 = 0,0182 ampere Poiché: DV = i R (per la prima legge di Ohm) R = DV/i = 220/0,0182 = 12088 ohm quindi circa 12 kw. Valore notevole della resistenza per l'alta temperatura a cui perviene il filamento dopo l'accensione. (Il valore misurato della resistenza del filamento a freddo è infatti risultato di un solo KW circa). Ricordiamo che l'incremento termico fa aumentare la resistenza nei conduttori solidi: ecco come la lampadina funge da resistenza variabile in un in finitissimo temporale. Per ciò concerne l'eliminazione dello starter dal circuito, diremo che sono più che sufficienti la cariche elettrostatiche, che tutti noi portiamo, per innescare la scarica iniziale semplicemente toccando il tubo a neon con una mano: ciò può destare notevole meraviglia per avere inizialmente supposto la presenza di un opportuno sensore (che non c'è) nel circuito di alimentazione. Una seconda versione è stata realizzata come lume da tavolo molto elegante con circolina a neon da 30 watt e globo luminoso con lampada da 60 watt; il tutto montato su di un piano di cristallo opaco di colore nero. L'accensione, anche in questo casa, avviene toccando la circolina con la mano. Quarto Exhibit (1999) Trattandosi di un motore essenziale a reazione il cui propellente è fornito da cariche elettrostatiche, si è pensato di chiamarlo come da titolo. Il motore è il risultato finale di un sistematico smontaggio e riduzione dei comportamenti della macchina elettrostatica di Whimshurst. A questo generatore elettrostatico sono stati tolti: manovella, pulegge a cinghia di trasmissione. Uno dei due dischi di materiale isolante controruotante è stato bloccato mentre l'altro è libero di ruotare con un minimo di attrito. Sono state mantenute le due bottiglie di Leyda, ma ai due pettini diametralmente opposti, con punte metalliche per indurre cariche sul disco, si sono applicate due spazzole morbide di tessuto metallico striscianti contro i piccoli segmenti metallici posizionati sul disco. Questo singolare motore si può alimentare o con una macchina elettrostatica ad effluvio Van de Graaff, oppure con un'altra macchina elettrostaticadi Whimshurst. Dopo alcuni istanti durante i quali il generatore carica le bottiglie di Leyda, si pone il disco in veloce rotazione: allora si osserva che la velocità del disco aumenta progressivamente fino a stabilizzarsi ad un valore notevole. Mediante lampada stroboscopia è stato possibile misurare una velocità di circa 800 giri al minuto. In qualità di "macchina per imparare" proporrei di utilizzare, come motore di alimentazione il generatore di Whimshurst. Ricordiamo inoltre che il motore non funziona con un'umidità relativa al 70% circa e la coppia motrice risulta limitata. Osservando il disegno si può stabilire quanto segue: la spazzola strisciante (A), collegata con polarità negativa del generatore, cede per contatto elettroni ai settori metallici posizionati sul disco isolante che, trascinati uno dopo l'altro dalla rotazione iniziale impressa volutamente al medesimo, (il vetro è indicato dalla freccia grande in alto) trasferiscono tutte queste cariche (e-) alla spazzola (B) che le attrae per la sua polarità positiva e le ricicla secondo il verso della freccia di (e-). I settori ora ritornati neutri, sono sottoposti ad una spinta reattiva nel verso opposto al verso delle cariche per cessione delle medesime. (Le frecce al centro del disco indicano il verso della spinta reattiva che incrementa la velocità di rotazione del medesimo). I settori metallici si riporteranno nella posizione iniziale della spazzola (A) per poi ricomincia re il ciclo. |